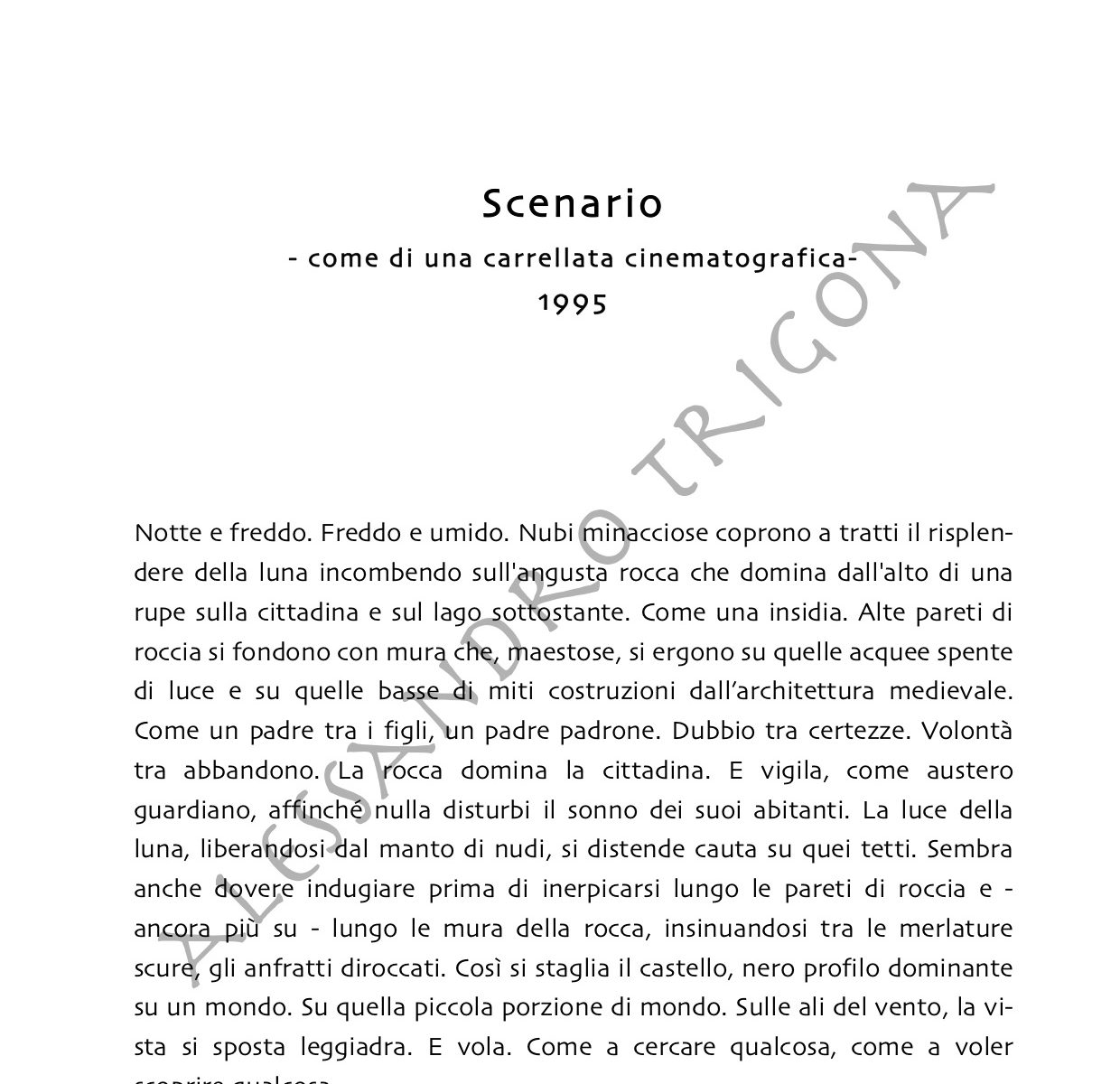– come di una carrellata cinematografica-
1995
Notte e freddo. Freddo e umido. Nubi minacciose coprono a tratti il risplendere della luna incombendo sull’angusta rocca che domina dall’alto di una rupe sulla cittadina e sul lago sottostante. Come una insidia. Alte pareti di roccia si fondono con mura che, maestose, si ergono su quelle acquee spente di luce e su quelle basse di miti costruzioni dall’architettura medievale. Come un padre tra i figli, un padre padrone. Dubbio tra certezze. Volontà tra abbandono. La rocca domina la cittadina. E vigila, come austero guardiano, affinché nulla disturbi il sonno dei suoi abitanti. La luce della luna, liberandosi dal manto di nudi, si distende cauta su quei tetti. Sembra anche dovere indugiare prima di inerpicarsi lungo le pareti di roccia e – ancora più su – lungo le mura della rocca, insinuandosi tra le merlature scure, gli anfratti diroccati. Così si staglia il castello, nero profilo dominante su un mondo. Su quella piccola porzione di mondo. Sulle ali del vento, la vista si sposta leggiadra. E vola. Come a cercare qualcosa, come a voler scoprire qualcosa.
La vista – la “nostra vista” – che, come in un’audace carrellata cinematografica, avanza e sale su per le pareti scoscese del monte, oltre la rocca. E vola su, più su. Vola in alto. Oltre la rocca. Oltre le sue mura di cinta. Lambendo pietre e rocce. Scorticandosi sulle sporgenze del pendio. E da lì, si sposta. Fino a scavalcare il muro per ricadere all’interno del maniero abbandonato dove gufi e serpi e ancora, pipistrelli vi hanno trovato rifugio. E casa. La rocca è zona di ombre più che di luci, dove tutto è silenzio. Ed è disperso tra il fragore di qualche sibilo, di qualche rantolio nascosto. O da qualche sbattere di ali, schioccare di lingua, stridere di denti famelici.
Ma la vista – la “nostra vista” – va oltre. Come a volere scoprire tutto, va oltre lo sbuffare di erba e cespugli incolti, oltre l’abbandono di quell’impervia rupe e sconfina giù, di nuovo, verso la cittadina che – come assopita – attende paziente. La vista allora vola giù verso i tetti delle case, verso le mura scolpite di palazzi, dalle persiane assonnate. Giù. Sdrucciolando tra le tegole e i nidi rapaci. E più giù: traversando un lungo camminamento. Oltre, abbandonandosi alle spalle le merlature, le feritoie, le torri sui tetti bassi di antiche case, sulla strada lastricata di pietre vecchie di secoli. Volteggiando lungo le vie strette del borgo medievale che vive rinchiuso – e come celato – all’ombra della vecchia rocca. Abbandonata.
E la vista – la “nostra vista” – decolla ancora tra il tremolare di un lampione, un soffio di vento, un lampeggiare di luna. Decolla tremante al fiato di un caldo brivido – come di paura, un’imprecisata, indefinibile sensazione di paura che pervade l’animo, il nostro animo. Antica inquietudine, come di un qualcosa che – forse – accadrà. Chissà.
E la vista – la “nostra vista” – vola ancora di nuovo in alto, passando sopra una piazza cinta da porticati dove oscillano, cupe, le ombre flebili di lampioni mentre l’umidità si leva a farsi nebbia padrona di una notte rigida di freddo – e non solo di freddo. La luce di un lampione – improvvisa – si sfuoca mentre la vista – la “nostra vista” – ondeggia, paurosa, librandosi sempre in una docile arcuata parabola che – carrellando – attraversa l’intera piazza ricercando qualcosa. Poi un rumore. Forse. A dare scossa alla vista – la “nostra vista” – che, sempre come in una carrellata cinematografica, plana sulla scena. Leggiadra, a seguire il rintocco di un rumore sordo di ritmici passi. Plana, come un soave invito a un profondo ragionamento, sommesso brusio che si disperde all’interno di una cattedrale gotica.
E plana ancora la vista – la “nostra vista” – sfiorando un lampione per infilarsi fin sotto un porticato di affreschi, dove – si intende – si coglie più forte il rumore sordo del passo di un uomo. Ecco allora emergere dal cicalecciare del silenzio, dal lampeggiare della nebbia, dal sonnecchiare dei fiacchi lampioni, la figura ammantata di un uomo che, a passi lenti, si inoltra lungo il portico. Prima lontano. Poi più vicino e sempre più vicino. Avanza l’uomo, incurante del tutto. Col volto nascosto dal freddo. Colle mani cucite nelle tasche. Si avanza.
E la vista – la “nostra vista” – allora si porge – incauta – a cercare un senso a quello scenario, a quella rocca, a quella notte cupa, colma di nebbia e freddo, a quelle case antiche di borgo. A cercare di dare un senso a quel camminare pigro. A darlo alla piazza, ai lampioni muti, al porticato, a quell’uomo che, solo, disperso e naufrago in uno scenario di tenebre, si avanza. Tutto così pieno. Tutto così vuoto.
Incauta, la vista – la “nostra vista” – si adagia allora, molle, sulla pavimentazione del portico ad ammirare la maestosità di quell’uomo che, nel freddo e nella notte e nella nebbia, avanza – silenzioso e solo – come senza perché. Incauta, la vista – la “nostra vista” – lo osserva, non scorta. Ancora incauta giace a lappare il movimento – sfumato nei tratti – di quel passo di uomo deciso che è vicino, sempre più vicino, ormai. Il suo oscuro vestito. Il suo lento andare. Il respiro affannato. È imponente mentre – pietra sul selciato – la vista – la “nostra vista” – da terra lo osserva ergersi a cammino nel portico. Figura imponente.
Incauta la vista – la “nostra vista” – da sotto indugia ancora ad inquadrarlo, ad ammirarlo, gigante, quale rocca che domina a picco la scena. Domina imponente. Un passo. E un passo. E un passo. Ancora. Un ultimo. E… ciac. Spiaccicata sul selciato – cicca di sigaretta – giace la vista – la “nostra vista” ormai spiaccicata da quell’uomo che, indifferente, si allontana fino a scomparire. Nella notte.